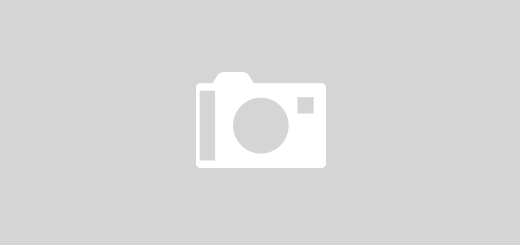La morte di un familiare lavoratore e il risarcimento del danno subito dall’azienda familiare
Un tema sovente non adeguatamente trattato e analizzato ha interessato direttamente l’attività difensionale dello studio Mangino, ossia quello relativo ai danni subiti da un’azienda a conduzione strettamente familiare in seguito al violento decesso ( per omicidio stradale) del fondatore della stessa. L’argomento è ovviamente molte delicato per tutte le implicazioni, non solo giuridiche, ma soprattutto personali e professionali che il citato omicidio colposo ha determinato e comporta a distanza di quasi tre anni dall’evento luttuoso.
Ebbene, la recentissima sentenza emessa dalla Suprema Corte di Cassazione civile, sez. III, ord., 18 gennaio 2023, n. 1386 –Presidente Rubino – Relatore Graziosi, ha posto l’accento sul non corretto ragionamento seguito dalla Corte d’Appello interessata della questione.
Secondo i Giudizi di Palazzo Spada i colleghi del secondo grado avrebbero errato nell’affermare che la morte di un familiare che presta la propria attività a vantaggio dell’impresa di famiglia non costituisca un danno patrimoniale, poiché tale lavoro “costituirebbe un dovere e non una facoltà” e che per ottenere il risarcimento occorra provare “il corso del rimpiazzo dell’utilità perduta”.
Nel caso di specie, due genitori sono ricorsi in Cassazione per poter ottenere il risarcimento del danno patrimoniale per l’avvenuta perdita del figlio in un incidente stradale, poiché quest’ultimo collaborava nel bar di famiglia da quando aveva 14 anni (apportando quindi un importante contributo patrimoniale, venuto meno). Secondo i ricorrenti il giudice d’appello avrebbe violato gli artt. 1223 e 2043 c.c., affermando che «avendo il figlio…il dovere giuridico di collaborare nell’impresa familiare, la sua morte non avrebbe arrecato alcun danno patrimoniale», facendo così dipendere la risarcibilità del danno rappresentato dalla «perduta possibilità di avvalersi del lavoro svolto dell’impresa familiare da uno dei familiari non dall’esistenza del danno, bensì dal titolo per cui si fruiva delle prestazioni lavorative del de cuius».
Detto titolo, invece, non avrebbe incidenza sull’utilità perduta in conseguenza del fatto illecito. Inoltre, deducono anche l’erronea affermazione secondo la quale il danno non era stato dimostrato per difetto di prova del “costo di rimpiazzo”, cioè la prova di aver assunto un nuovo collaboratore.
Secondo l’insegnamento della Suprema Corte, il risarcimento del danno da fatto illecito «ha la funzione di porre il patrimonio del danneggiato nello stesso stato in cui si sarebbe trovato senza l’evento lesivo stesso e, quindi, trova presupposto e limite nell’effettiva perdita subita da quel patrimonio, in conseguenza del fatto stesso, indipendentemente dagli esborsi materialmente effettuati» (ex multis Cass. n. 9740/2002, n. 7389/1987, n. 4718/2016, n. 22826/2010).
La Corte d’appello non ha, quindi, applicato correttamente l’art. 1223 c.c., escludendo il danno patrimoniale relativo alla perdita della collaborazione del de cuius all’impresa di famiglia.
Per tutti i superiori motivi il Collegio ha cassato la pronuncia resa in grado appello e ha espresso il seguente principio di diritto: «per ottenere il risarcimento della “perdita subita” ai sensi dell’art. 1223 c.c. non occorre che il danneggiato si sia preventivamente attivato per ripianare detta perdita, così da dimostrare di avere sostenuto le spese allo scopo necessarie, non sussistendo alcuna obbligazione in tal senso».